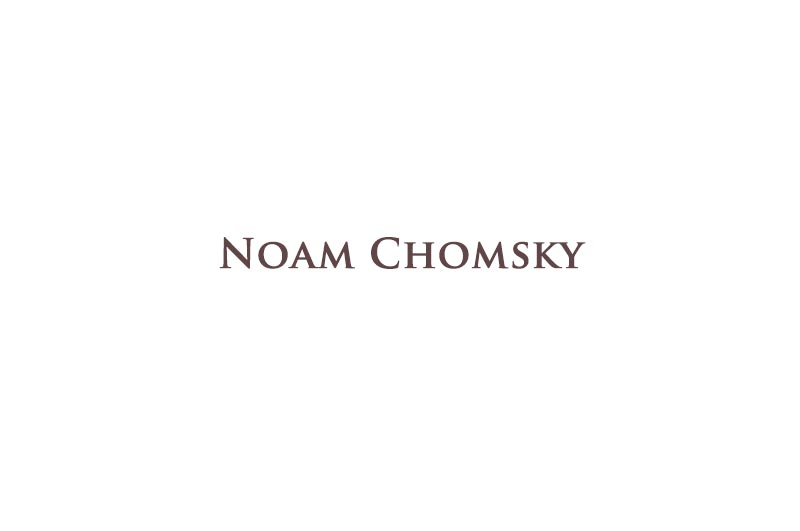La prima domanda che mi venne in mente di fargli, appena dopo esserci seduti, fu: “Ma lei perché, pur lavorando in una struttura governativa statunitense, critica così aspramente il modello degli Stati Uniti?”
Forse, a pensarci bene, come inizio poteva sembrare un po’ aggressivo, ma lui mi rispose con un disinvolto sorriso:
“In realtà non ne parlo male, mi limito a denunciare quei singoli aspetti del sistema americano che andrebbero corretti. E poi credo che un paese in cui è concessa l’autocritica sia la dimostrazione più evidente di una democrazia efficace”.
Era il 1997 e il nostro primo incontro avvenne al MIT di Boston, dove mi presentai accompagnato da Mel Goldzband, che aveva a sua volta pubblicato un libro con la mia casa editrice.
Prima di entrare guardai l’orologio: bene, pensai, ho esattamente tre ore; questo infatti era il tempo che Chomsky – come da accordi presi in precedenza – mi avrebbe concesso. Ci ospitò nel suo ufficio al MIT.
Come quasi tutti gli uffici di scienziati e docenti universitari che avevo visitato fino a quel momento, anche questo era una stanza angusta – tanto stretta da contenere a malapena noi tre – con pochi mobili, ma molti libri e fogli sparsi ovunque. Sulla scrivania c’era la foto di una donna, sua moglie Carol, con la quale poi ho proseguito i miei scambi telematici in merito agli accordi per la pubblicazione del libro.
L’ufficio di Chomsky
L’ala in cui si trovava l’ufficio di Noam Chomsky era abbastanza vecchia e per nulla dissimile da una struttura universitaria italiana, dove il peso dei decenni si fa sentire… e vedere.
Rimasi sorpreso dal fatto che una personalità come Chomsky fosse stato relegato in una struttura così poco accogliente, ma lui non diede segno di farci caso. Anche quando la quantità di ossigeno nel suo ufficio cominciò a scarseggiare, continuò a parlare come se nulla fosse, piacevolmente coinvolto dal nostro discorrere. Quanto avrei voluto aprire la finestra!
Disse che l’idea di tirare fuori un’autobiografia da un’intervista registrata gli sembrava assolutamente geniale:
“Sa quanto tempo avrei risparmiato nella mia vita se tutti gli editori avessero fatto così, invece di costringermi a scrivere pagine su pagine e poi rileggerle, correggerle? Geniale!”
Lo ringraziai lusingato, ma non osai dirgli che più che “geniale” lo trovavo “semplice” ed estremamente “pratico”.
A quel punto, mi venne la curiosità di sapere come mai aveva accettato il mio invito a pubblicare un’autobiografia: c’entrava solo la “genialità” dell’idea? “No, non solo”, mi rispose:
“Ho visto che tra i titoli della sua collana c’era anche la biografia di Edoardo Boncinelli, uno scienziato che apprezzo molto, per la sua poliedricità e onestà intellettuale, ma in modo particolare per gli studi che egli ha condotto sul cervello, studi che a me sono serviti moltissimo. Diciamo che lui è stato il motivo per cui ho accettato”.
Gli avevo infatti mandato, come esempi della collana, sia il libro di Boncinelli che quello della Hack. Disse che ambedue i nomi gli avevano dato la garanzia del fatto che si trattasse di una cosa seria:
“Sa, non si racconta mica della propria vita al primo venuto!”
Esclamò soddisfatto. Poi aggiunse, quasi fosse una confidenza da non divulgare:
“Mi piace aiutare i piccoli editori, perché sono gli unici che portano avanti idee nuove e che hanno il coraggio di tentare percorsi inediti”.
Chomsky, uomo complesso
Quando ci salutammo mi sentivo logorato da un sentimento ambiguo: da una parte ero molto contento del clima che si era creato, dall’altro mi rendevo conto che tre ore erano davvero poche per sondare la vita di un uomo così complesso. Mi dispiaceva, ad esempio, di non aver potuto approfondire taluni aspetti della linguistica.
Ma lui fu così gentile da venirmi incontro: mi diede infatti un articolo, ancora inedito, che trattava proprio degli argomenti che avrei voluto ampliare. Poi assistetti a qualcosa di assolutamente inverosimile per un italiano: quando, salutandoci, aprì la porta del suo studio, trovammo – seduti a terra o con le spalle appoggiate al muro – alcuni studenti, vestiti in calzoncini corti e maglietta.
Era evidente che erano lì per lui. Sentii che qualcuno faceva delle domande, ma quelli che erano seduti in terra non fecero il minimo gesto per alzarsi. E Chomsky, come se fosse la cosa più naturale del mondo, si chinò e cominciò a rispondere ai quesiti che gli venivano posti. È vero, gli americani amano essere informali, dovrei esserci abituato ormai, eppure ogni volta me ne meraviglio.
Qualche tempo dopo la pubblicazione del libro di Chomsky nella collana “I Dialoghi”, mi chiamò un giornalista di Rai Tre per chiedermi come avevo fatto proprio “io” – e il sottinteso era: “piccolo editore sconosciuto” – ad essere ricevuto da Chomsky, visto che da anni non concedeva più interviste a nessuno.
Mi chiese anche se potevo intercedere in qualche modo in suo favore, ma mi limitai a fornirgli mail e numero di fax – dati peraltro già pubblici – dicendogli che avevo semplicemente tentato la fortuna!
E Chomsky per me, in un certo senso, è stato una fortuna. Non solo per l’intervista che mi ha concesso, ma soprattutto perché il suo nome ha conferito alla mia collana, fino a quel momento ancora “nascente”, un riscontro internazionale. Anche se in America non tutti lo amano, tutti lo conoscono e lo rispettano: per il coraggio delle sue idee, delle sue parole e dei suoi studi.